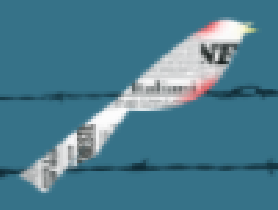Quel che resta di un uomo. Vivere, sopravvivere, resistere e morire sotto la dittatura nazionalsocialista (1933-1945)
In memoria di tutti i cittadini italiani, ebrei e non ebrei, che furono deportati nei campi di concentramento e di sterminio nazisti da dove molti non fecero più ritorno.
Voi che vivete sicuri
Nelle vostre tiepide case,
Voi che trovate tornando a sera
Il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango
Che non conosce pace
Che lotta per mezzo pane
Che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna,
Senza capelli e senza nome
Senza più forza di ricordare
Vuoti gli occhi e freddo il grembo
Come una rana d'inverno.
Meditate chequesto è stato:
Vi comando queste parole
Scolpitele nel vostro cuore
Stando in casa andando per via,
Coricandovi alzandovi;
Ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
La malattia vi impedisca,
I vostri nati torcano il viso da voi.
Shemà, Primo Levi, 10 gennaio 1946 (pubblicata in Se questo è un uomo, De Silva, 1946)
Quest'anno gli studenti di quinta superiore di tutte le scuole di Rimini, viene proposto un seminario di formazione che si svolge da fine ottobre 2015 ad aprile 2016.
Come indica il titolo stesso, “Quel che resta di un uomo”, il seminario vuole indagare e discutere il tema dell’umano e del disumano sotto la dittatura nazista di Adolf Hitler (e dei suoi collaboratori). In nome di una concezione dell’umanità fondata sul razzismo biologico (cioè non tanto sulla gerarchia tra razze superiori e razze inferiori, quanto soprattutto sull’idea che il sangue costituisca l’identità e il valore immutabile di un individuo e di un popolo), il regime nazista emarginò, perseguitò e mandò a morire milioni di innocenti. La Shoah è il nome ebraico con cui si chiama il genocidio degli ebrei d’Europa che furono assassinati nel corso della Seconda guerra mondiale per la sola colpa di essere nati ebrei. Ma anche altre categorie di persone subirono gli effetti di questa politica razziale e totalitaria con destini diversi, a seconda del gruppo di appartenenza (gli oppositori politici, i criminali comuni, i Testimoni di Geova, gli asociali, i disabili, gli omosessuali, gli zingari, i prigionieri di guerra), ma anche con caratteristiche comuni relativamente all’esperienza del lager che fu sempre contrassegnata dalla fame, dalla violenza e dalla privazione assoluta di diritti.
In modo particolare, quest’anno è proprio l’esperienza estrema - in quanto eccezionale per la sua anormalità e per le sue tragiche proporzioni - dei campi di concentramento che ci proponiamo di approfondire. I sopravvissuti che riuscirono a rimanere in vita fino alla fine della guerra conservarono un ricordo traumatico e indelebile della sofferenza e del male patito nei lager, in cui la scala dei valori era rovesciata. Privati di tutto, del proprio nome, sostituito da un numero, e della propria dignità, sottoposti a ogni crudeltà e umiliazione, i prigionieri dei lager si trovarono nella condizione di provare disperatamente a sopravvivere in un luogo infernale dalle regole incomprensibili, talvolta scendendo a compromessi con la propria dignità, talvolta invece preservando con grande sacrificio quel barlume di decenza e di moralità in grado di tracciare un confine con la barbarie indotta dai propri carnefici. Ad esempio, continuare a lavarsi con l’acqua putrida e gelata per contrastare il processo di abbrutimento e degradazione, oppure non rubare il tozzo di pane al proprio compagno quando la fame annebbiava il cervello e prostrava il corpo, erano gesti che richiedevano coraggio e coscienza, capaci di proteggere i deportati dalla sensazione terribile di sentirsi diventati “bestie come i loro aguzzini”. Il giovanissimo Elie Wiesel, deportato nel 1944 come ebreo insieme alla sua famiglia ad Auschwitz e poi a Buchenwald, racconta nel suo libro-testimonianza più celebre, La notte, che un giorno desiderò la morte dell’amato padre, ormai moribondo, per potergli rubare l’ultimo tozzo di pane. Nel momento stesso in cui Elie Wiesel formulò questo pensiero, provò vergogna, chiedendosi fino a che punto il lager lo avesse degradato.
D’altro canto, invece, per i carnefici la normalità corrispondeva banalmente al “lavoro” da svolgere: annientare psicologicamente e fisicamente i prigionieri, la cui vita non aveva alcun valore. Portare a termine il proprio compito di persecutori o assassini rientrava in buona sostanza nel loro dovere di dimostrarsi degni di appartenere alla “razza eletta degli Ariani”. Il regime promuoveva un’ideologia affascinante per coloro che stavano dalla parte degli eletti, perché per innalzare alcuni (i tedeschi “ariani”) richiedeva “il sacrificio” di escludere ed annientare senza pietà tutti gli elementi ritenuti indesiderati, malati, improduttivi, di razza inferiore o pericolosi. I medici nazisti che uccisero senza pietà bambini o adulti malati non erano pazzi o sadici, ma medici che sposarono l’idea di un diritto alla vita solo per alcuni, coloro che potevano dimostrare di essere non solo “ariani” ma in perfetta salute fisica e psichica.
Il fatto che il comandante del centro di sterminio di Treblinka, Franz Stangl, fosse anche un ottimo marito e un amorevole padre di famiglia, un uomo non violento nella sua quotidianità, beneducato e di una certa cultura, non va visto come contraddizione in sé. La maggioranza dei carnefici furono uomini e donne comuni, spesso cristiani o religiosi, con un’istruzione superiore, individui come tanti che agirono perché compiere il male rappresentava ai loro occhi un dovere nobile e necessario, non un crimine.
Ecco allora che torna la nostra domanda di partenza: cosa resta di un uomo in tali condizioni?
Vogliamo, dunque, riflettere sul fatto che la maggioranza delle vittime e dei carnefici della Shoah non furono esseri umani straordinari per qualità morali elevate o spregevoli, per capacità intellettiva o per le azioni compiute, ma furono invece uomini e donne comuni, quasi banali, nella loro normalità.
Furono però le circostanze particolari dell’epoca in cui vissero a influenzare e a rendere la loro vita drammaticamente fuori dal comune (quindi stra-ordinaria), ovvero il contesto storico-politico che coincise con l’ascesa e la caduta di Adolf Hitler e col regime nazista che per 12 anni influenzò le sorti di milioni di persone. Non è vero che in ogni uomo sonnecchi un potenziale assassino, cioè credere che chiunque possa diventare, in situazioni simili, un crudele persecutore di innocenti. Perché se è vero che la maggioranza non si oppose al nazismo (come in Italia non si oppose al fascismo prima dell’autunno 1943) e lasciò il male compiersi, va ricordato che ci furono una minoranza di uomini e donne, anche giovanissimi, che seguirono la propria legge morale, non rimasero a guardare, si adoperarono per prestare soccorso ai perseguitati o quanto meno non aderirono ad un’ideologia che giustificava i peggiori crimini come necessità per la sopravvivenza e per il benessere del popolo tedesco.
Non si tratta, quindi, di indagare genericamente l’astratta capacità dell’uomo di compiere le peggiori nefandezze o gli atti più eroici e caritatevoli, ma di indagare cosa resti di umano in un contesto politico specifico come quello di una dittatura totalitaria, il nazionalsocialismo (ma anche il fascismo a cui faremo frequenti accenni), segnato da un’ideologia razzista e antisemita, dall’omologazione, dalla paura, dall’opportunismo, dall’assuefazione alla violenza.
Vogliamo riflettere su come in circostanze estreme, l’uomo risponda ai propri dilemmi morali e al peso della sopraffazione, decidendo se restare, appunto, umano e con quale significato per il termine di umanità. Oppure cosa faccia di un uomo un carnefice (e il carnefice non è solo colui che materialmente uccide, ma anche colui che pensa il crimine, lo agevola, vi partecipa), quando si verificano determinate condizioni culturali e politiche.
In questo tentativo di stare rigorosamente ancorati alla narrazione storica del nazismo – senza la quale nulla si spiega – ma al contempo di ricondurre la tragedia della deportazione e della Shoah all’uomo e all’umano, cercheremo di stimolarvi a formulare ipotesi interpretative e giudizi politici (oltre che morali) sull’adesione o, al contrario, sulla resistenza al male, per coerenza con il principio di educazione alla responsabilità individuale che regge tutta l’Attività di Educazione alla Memoria di cui il Comune di Rimini si occupa da oltre mezzo secolo.
Vogliamo interrogarci sui dilemmi umani che ci spingono a reagire o a non reagire al male, o viceversa a compiere il bene.
Ma soprattutto vogliamo discutere di come il valore della vita umana non possa essere materia politica. Cosa ci insegna allora il nazismo, con la sua visione dell’umanità brutalmente razzista e animalista, fondata sia su idee razziali tradizionali che sull’idea del sangue puro da non contaminare e da non disperdere? Qual’è il legame con la nostra vita di oggi?