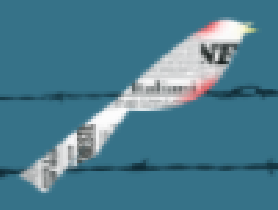SE QUESTO E' UN UOMO
di Primo Levi
Se questo è un uomo No, non è la dissoluzione dell’io pirandelliano, non è un romanzo dell’anima di Dostoevskij e nemmeno un saggio verista di Captano o Verga. Questa è la testimonianza di un uomo. Un uomo vittima di un processo di annullamento fisico, psichico e morale, privato, insieme a milioni di persone, delle dignità e delle identità, e ridotto a un puro numero. Questo era stato il suo nome: 174 517. Il nome di un corpo nudo e infreddolito, stritolato dalle morse della fame e della sete, che ha combattuto una spietata lotta per la sopravvivenza in un campo di concentramento nazista. L’autore si serve di un linguaggio semplice e piano, facile alla comprensione per chiunque. La struttura del periodo è suddivisa ripetutamente in proposizioni brevi e compiute, e questo, a mio parere, riflette la frantumazione interiore di Levi che racconta: quelle strazianti esperienze lo hanno segnato e nel comunicarle non può fare a meno di riprodurne la crudezza e quel profondo senso di degradazione di cui sono madide. (“Innumerevoli sono le proibizioni: avvicinarsi a meno di due metri dal filo spinato; dormire con la giacca o con il cappello in testa;….Portare sotto gli abiti carta o paglia contro il freddo; lavarsi altrimenti che a torso nudo”. Tutto rimanda alla rigidità delle regole e dei Kapos che le comunicavano). Il racconto è condotto al presente indicativo, ovvero nel modo della realtà e nel tempo che descrive gli avvenimenti quando accadono. E’ il segno evidente che nel suo cuore rimane acceso e ardente il ricordo di quegli orrori: addirittura si ritiene che gli strascichi psicologici dell’internamento nel campo di sterminio furono la principale causa del suo suicidio, avvenuto nel 1987. Ma d’altronde egli cominciò subito a narrare, dopo la liberazione e la sua peregrinazione nell’Europa dell’Est (raccontata ne “La Tregua”), prima del ritorno a Torino. La stesura di “Se questo è un uomo” lo impegnò per due anni fino alla pubblicazione del 1947. E pensare che solo nove anni prima, il 14 luglio 1938, venne pubblicato il documento “Il fascismo e i problemi di razza”, che insieme ad un apparato di leggi razziali, inaugurarono quella campagna discriminatoria volta ad allontanare progressivamente gli ebrei dalla vita nazionale. Basti pensare che tra il 1938 e il 1943, gli oltre 40.000 ebrei italiani vennero privati dei diritti civili e politici, furono cacciati dalle scuole, dalle università, dai posti di lavoro che ricoprivano da anni:una politica che vedrà gli ebrei italiani denigrati ed emarginati sempre più dalla società, fino ad arrivare alla svolta del 1943. Nell’anno dell’armistizio, la neonata Repubblica Sociale Italiana continuò le persecuzioni ebraiche, ma a sfondo criminale, con migliaia di eccidi, rappresaglie, fucilazioni e stermini di massa, a fianco della potenza tedesca, che non mancava per nulla di sostenere la Repubblica fascista contro l’ormai crescente opposizione partigiana. In questi mesi gli ebrei italiani persero tutti i loro beni, e le loro vite furono rinchiuse nei campi di internamento che stavano sorgendo a macchia d’olio anche nella penisola: a Fossoli (Modena), a Gries (Bolzano), a San Sabba (Trieste)… queste aree divennero i centri di raccolta dai quali partivano migliaia di prigionieri per la Germania, dove pochi sarebbero sopravvissuti e molti mandati a morte. Ed è proprio in questo contesto che si colloca la vicenda del nostro autore. Primo Levi, giovane partigiano, venne catturato dai fascisti alla fine del 1943; si dichiarò ebreo per nascondere la sua attività politica e giustificare così la sua presenza sulle montagne. Dopo un breve periodo trascorso nel campo di Fossoli, nei pressi di Modena, fu deportato in Polonia nel febbraio del 1944. Come enuncia nella prefazione, fu un momento fortunato, dopo che il governo tedesco, data la crescente scarsità di manodopera, aveva stabilito di allungare la vita media dei detenuti da eliminare, con un conseguente “miglioramento” ( se di miglioramento si può parlare) del tenore di vita. Imprigionato nel lager, venne assegnato alla fabbrica di gomma di Buna-Monowitz, una condizione di relativo privilegio che è fra le ragioni della sua sopravvivenza. Una cosa che mi ha colpito singolarmente è stato l’impiego della prima persona plurale per buona parte della narrazione: “Abbiamo imparato che tutto serve….Conosciamo già in buona parte il regolamento del campo….Noi giacevamo in un mondo di morti e larve”. L’autore, dunque, non vuole limitarsi a raccontare la sua esperienza, ma volge gli occhi e il cuore a tutti i prigionieri, che hanno condiviso con lui lo stesso destino, le stesse atrocità e lo stesso sentimento di smarrimento esistenziale. Ha cercato di dar voce e di incarnare lo spirito di tutte quelle persone, a cui la morte ha tolto la possibilità di raccontare le brutalità patite. In questo spirito di solidarietà umana, credo che Levi si sia fatto portavoce anche di ciò, ricordando quel “mondo di morti e di larve”, come scrive nel finale, su cui giacevano, tra gli altri, alcuni suoi compagni. Quella di Levi è un’opera “universale”, direi, perché non si rivolge a qualcuno in particolare: il suo interlocutore è l’umanità intera, che deve provare risentimento ed orrore di fronte a queste pagine. Il libro è stato scritto di getto: il bisogno di raccontare l’esperienza dilaniante patita nel lager si è fatto sempre più premente in lui con il primario scopo di liberazione interiore, come afferma nella prefazione. E nello sfogliare quelle pagine di odio e di dolore più volte la mia mente tentava di immergersi nella realtà descritta. Provavo pensare all’ Auschwitz che ho visto nel documentario “Memoria”, con quel suo grigiore, incerto, scolorito, quasi a voler esprimere anch’esso il ribrezzo di fronte ai delitto consumatisi ai suoi piedi sessant’anni prima. In quell’ambiente tutto è parso grigio, tutto tragicamente uniforme e spento. Eppure ancora risuonano più che mai ardenti quelle che, a mio parere, sono forse le parole più struggenti del testo: “Nulla è più nostro: ci hanno tolto gli abiti, le scarpe, anche i capelli; se parleremo non ci ascolteranno, e se ci ascoltassero, non ci capirebbero. Ci toglieranno anche il nome: e se vorremo conservarlo, dovremo trovare in noi la forza di farlo, di fare si che dietro al nome qualcosa ancora di noi, di noi che eravamo, rimanga.[…] In un attimo la realtà ci si è rivelata. Siamo arrivati al fondo”. Chi di noi non prova sgomento a queste testimonianze? Chi non si sente per un istante un gelo nel cuore che gli dice: “Ecco, è stato così?”. E mi fa innervosire chi si ripete le solite frasi fatte sentire in televisione: “Dobbiamo ricordare per non commettere gli stessi errori”. Ma quali errori! Qui non si tratta di errori, qui c’è dietro un progetto calcolatore di messa a morte sistematica! Si tratta di prendere atto che nel XXI secolo una parte del genere umano è approdato alla follia, al sadismo, al delirio di onnipotenza incarnato in figure come Hitler, Stalin, Chiang Kai-Shek, quanti altri… Altro che l’ “Homo homini lupus” di Hobbes! E’ arrivato l’ “Homo hominis diabolus”! Ad ogni modo, la lettura di “Se questo è un uomo” ma ha arricchito molto, e mi ha subito richiamato alla mente un altro testo che ho letto poco tempo fa: “La metamorfosi” di Kafka. Lo stesso senso di abbandono, di emarginazione sociale, di isolamento interiore si manifesta nell’opera dello scrittore cieco, che, seppur allegoricamente, descrive con grande efficacia la precarietà di un’esistenza che non gli ha mai detto niente. Particolarmente commovente è la scena in cui Gregor Samsa, l’insetto protagonista attaccato alle pareti di casa, viene bersagliato dalle mele lanciate dal suo stesso padre. Che tenta così di eliminarlo. Ecco dunque che esplode quel senso di straniamento esistenziale, in cui kafka si è proprio ritrovato, anche in famiglia. Non è un caso che proprio Primo Levi parli dello scrittore cieco con grande ammirazione: “Kafka comprendo il mondo, il suo e anche meglio il nostro di oggi, con una chiaroveggenza che stupisce, e ferisce come una luce troppo intensa. Già, proprio quella luce accecante dell’esistenza che Levi ha deciso di spegnere nel 1987.
Recensione di Federico Polverelli Liceo classico Giulio Cesare